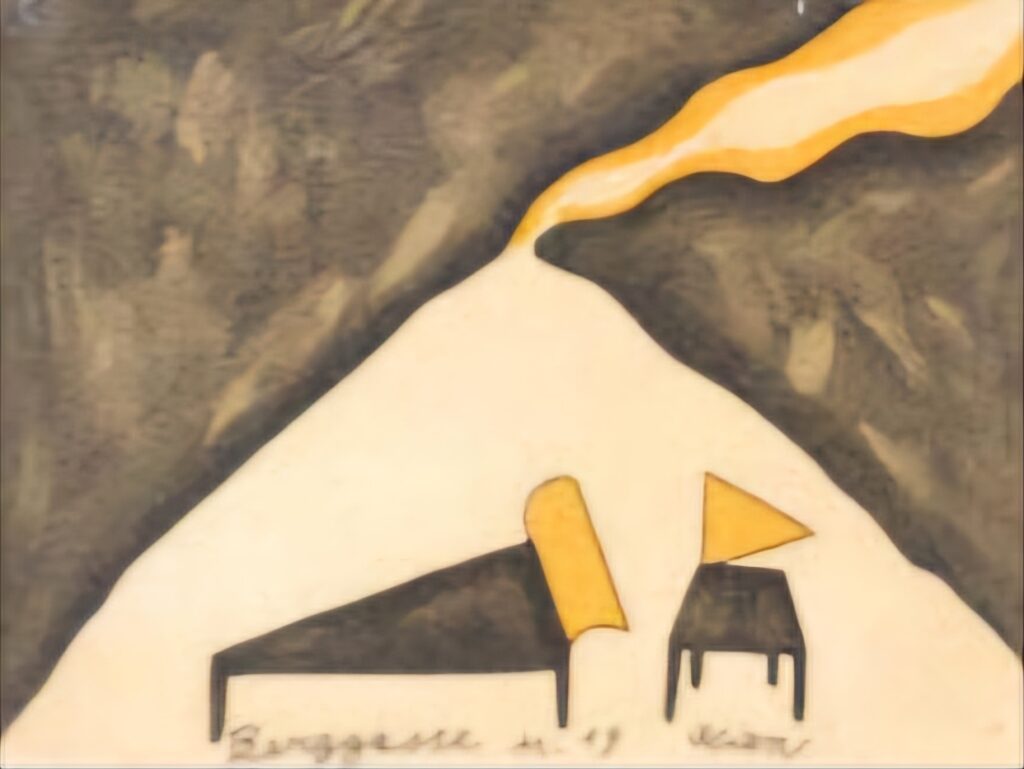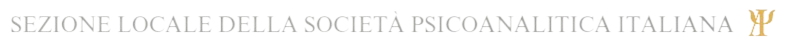Eros e disperazione psicotica*
di Celestino Genovese
Traduzione di Darwin Mervoglino
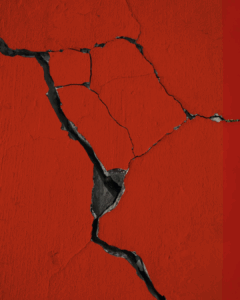
*Questo articolo è stato pubblicato originariamente in lingua inglese nel 2006, su The Psychoanalytic Quarterly, con il titolo Eros and psychotic dispair. Successivamente è stato ripubblicato, sempre in lingua inglese, nell’antologia di C. Genovese Al di qua o al di sotto del sessuale?, edita da Alpes nel 2024, pubblicazione postuma a cura di D. Mervoglino e R. Galiani.
Sebbene sia plausibile ritenere che una prima stesura fosse stata scritta in italiano, non ne è stata rinvenuta traccia. Il testo che segue è, ad eccezione della bibliografia, frutto di una traduzione dall’inglese. Dell’originale non vengono riportate le note a piè di pagina.
L’erotomania e il suo rapporto con la psicosi e la compulsione amorosa
Verso la fine dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento il tema dell’erotomania trovò una certa applicazione nella psichiatria classica. Questo concetto nosografico è venuto a indicare la costruzione delirante di una trama erotica in cui il soggetto è rappresentato come oggetto d’amore e molto spesso come protagonista/vittima di un interesse sessuale o di persecuzione da parte di uno o più personaggi famosi.
Come tutti i concetti nosografici, una volta inserito in un contesto di interpretazione psicoanalitica, esso perde la sua forza e la fantasia o il delirio erotomanici diventano una delle espressioni dei possibili sintomi della sofferenza psichica. Freud (1908, 1911) usò il termine solo due volte ed esclusivamente per scopi descrittivi in accordo con il modello psichiatrico.
Anche Lacan utilizzò il concetto nella sua tesi di dottorato del 1932 prima di dedicarsi alla psicoanalisi. In ogni caso in Francia, più in generale, il concetto ricevette molta più attenzione ma anche qui la discussione psicoanalitica si spostò ben presto sul tema dei problemi più generali riguardanti la paranoia, e soprattutto sulle tesi presentate da Freud (1911) nel suo saggio su D. P. Schreber. In effetti il tema dell’erotomania, da allora, si è inevitabilmente dissolto nell’area di pertinenza della psicosi paranoide.
Recentemente, tuttavia, una rivista francese (Penser/Rever, 2004) ha ravvivato l’interesse sull’argomento dedicando un intero numero all’erotomania in un senso molto più ampio. Oltre al suo significato psichiatrico classico vengono presi in considerazione i “nuovi erotomani” così come sono descritti nella letteratura e nel pensiero correnti. Nell’ottica rilanciata in questa pubblicazione, l’erotomane è visto come una persona ossessionata da tutto ciò che è erotico, in un senso molto ampio, e i contributi in essa contenuti avanzano l’idea secondo cui l’erotomania sia una componente della passione amorosa in generale.
Tralasciando quest’ultimo punto, ci si può soffermare a considerare il fatto che una sola parola, erotomania, nata per indicare una patologia psicotica, è praticamente scomparsa dalla letteratura scientifica ed ha assunto un significato completamente diverso nel linguaggio corrente. Ora, invece di indicare le trame articolate di fantasie deliranti a contenuto amoroso, allude ad un comportamento sessuale quasi indiscriminato e compulsivo. Si passa cioè concettualmente dalla centralità delle rappresentazioni, anche se psicotiche, alla centralità dell’azione, che si avvicina molto ad una soluzione perversa. L’unico punto in comune tra le due definizioni accettate del termine è l’assenza di qualsiasi relazione oggettuale autentica. Tuttavia, sotto la superficie, è possibile che queste due definizioni di erotomania possano riflettere due facce della stessa medaglia.
In questo articolo intendo mostrare come sia la sindrome erotomanica descritta dalla psichiatria classica, sia quella caratterizzata dall’agito sessuale compulsivo, siano in realtà due soluzioni diverse allo stesso problema: entrambe esprimono la necessità di utilizzare la sessualità per realizzare risultati non sessuali e di affrontare la disperazione psicotica attraverso fantasie più o meno deliranti o attraverso comportamenti di varia natura.
Con l’espressione disperazione psicotica mi riferisco, in senso lato, a uno spettro di possibilità: a partire dalla sofferenza psichica presente nella psicosi franca (nei deliri paranoidi, per esempio), fino a quella riscontrabile nei nuclei psicotici di gravi pazienti borderline e, infine, a quella che sembra nascondersi dietro un comportamento sessuale compulsivo. Secondo la mia ipotesi, quest’ultima potrebbe essere espressione di nuclei psicotici latenti.
Nella seconda parte di questo articolo presenterò una esemplificazione clinica riguardante un grave paziente borderline con fantasie erotomaniche e agiti pseudo-sessuali. Il mio focus è sulla relazione tra eros e patologia psicotica, così come tra eros e comportamento amoroso compulsivo. L’esame e la discussione di questo rapporto nasce per la prima volta con Freud ed è da qui che dobbiamo necessariamente partire per esplorare i nodi originari del problema, il più importante dei quali è la scelta di estendere il potenziale esplicativo della teoria sessuale dalla nevrosi alla psicosi.
L’origine del problema: psicosi e teoria sessuale
Sebbene Freud (1895, 1896a, 1896b) si sia occupato fin dall’inizio della paranoia, il suo primo vero saggio psicoanalitico sull’argomento apparve solo nel 1911: il suo commento all’autobiografia di Schreber. Si tratta di un saggio affascinante sia per il suo contenuto scientifico che storico. Per quanto riguarda il primo, troviamo qui una descrizione della dinamica del meccanismo della proiezione; il secondo getta luce sulle vicissitudini del rapporto di Freud con Jung, che possono essere lette in un modo nuovo che potrebbe contribuire ad una diversa visione dei problemi che qui ci interessano.
È noto che componenti importanti della teoria freudiana sulla paranoia derivano dagli studi di Jung (1907) e da quelli di Abraham (1908), che tentarono di collegare la dementia praecox alla sessualità infantile. Sappiamo anche che, quando Jung (che originariamente aveva consigliato il libro di Schreber a Freud) lesse il saggio di Freud (1911), la sua reazione sfavorevole divenne uno dei motivi del suo più generale disaccordo con il maestro. La critica di Jung è certamente antecedente alla pubblicazione ufficiale del saggio di Freud e riguardava più in generale la libido come pulsione sessuale; tuttavia, può darsi che questo saggio del 1911 (in particolare la terza parte, sul meccanismo della paranoia) abbia segnato una tappa importante nella loro rottura, dato che alcuni dei suoi passaggi potrebbero aver dato a Jung l’opportunità di affinare e focalizzare la sua critica.
Una conferma di ciò è quella che sembra essere la difesa un po’ doverosa ma ingenua di Freud da parte di Jones (1953), quando riconobbe che questo saggio segnava l’inizio del litigio Freud-Jung. Secondo Jones alcuni passaggi leggermente ambigui nel testo potevano essere attribuiti al carattere della lingua tedesca, meno preciso sia dell’inglese che del francese, e Jung potrebbe aver letto uno di questi in un senso che Freud non aveva inteso affermare. Ma Jones non fece nessun tentativo di indicare alcun passaggio specifico che, secondo lui, Jung aveva frainteso. Resta tuttavia l’impressione che il disaccordo non riguardasse tanto la questione teorica della libido in sé.
Io avanzo l’ipotesi secondo cui la sensibilità di Freud nei confronti delle critiche di Jung fu accresciuta dalla sua stessa delusione, per il fatto che il suo primo tentativo di spiegare i processi psicotici nella teoria psicoanalitica avesse prodotto un risultato che non corrispondeva alle sue aspirazioni. Altrimenti come interpretare la prima parte del poscritto che egli si sentì obbligato ad aggiungere al commento di Schreber, un anno dopo?
Sono fiducioso che ogni lettore con una conoscenza di psicoanalisi avrà imparato dal materiale da me presentato più di quanto non sia stato da me esplicitamente affermato, e che non avrà avuto difficoltà a riannodare le fila e a giungere a conclusioni alle quali io non ho più che accennato. [Freud 1911, p. 80]
Pertanto, il vero problema di Freud non riguardava la teoria della libido in generale – che, dai tempi dei Tre saggi sulla teoria sessuale (1905) in poi, poggiava su solide basi – ma piuttosto la difficoltà di utilizzare la teoria della libido come strumento esplicativo per l’eziologia paranoide, e probabilmente per l’intero complesso della patologia psicotica.
Penso che queste preoccupazioni possano, in una certa misura, aver influenzato lo studio più dettagliato sul narcisismo che portò Freud (1914) a costruire fasi di sviluppo arcaiche e a prestare costante attenzione alla conciliazione di queste nuove idee con aspetti precedentemente sviluppati della teoria delle pulsioni, arrivando talvolta a formulazioni per nulla facili da comprendere (Genovese 2003).
Ma, per tornare al testo di Freud (1911) su Schreber, ricordiamo le sue esatte parole:
Il paziente ha ritirato dalle persone del suo ambiente e, in generale, dal mondo esterno l’investimento libidico che finora aveva diretto su di loro. Così, tutto è diventato per lui indifferente e irrilevante […] La fine del mondo è la proiezione di questa catastrofe interna; il suo mondo soggettivo è giunto al termine da quando ne ha ritirato il suo amore. [P. 70, corsivo aggiunto]
Sottolineo qui il termine catastrofe interna perché questo è il punto cardinale dell’argomentazione di Freud. Alla luce di questo passaggio la catastrofe appare conseguenza di un disinvestimento libidico che non è affatto specifico della paranoia; né il disinvestimento libidico produce necessariamente catastrofi. Freud è ben consapevole del problema e continua:
Il distacco della libido […] non può essere di per sé il fattore patogeno della paranoia; deve esserci qualche caratteristica speciale che distingue il distacco paranoico dalla libido da altri tipi […] Da ciò si può concludere che nella paranoia la libido liberata si attacca all’Io e viene utilizzata per l’ingrandimento dell’Io. [1911, pag. 72]
Possiamo quindi vedere che la caratteristica unica di questa sindrome psicopatologica sarebbe la destinazione della libido dopo il suo ritiro dal mondo esterno. Tuttavia, se dovessimo concludere con questa osservazione, ci ritroveremmo con una descrizione fenomenologica piuttosto che con una teoria esplicativa; inoltre rimarrebbe il problema della catastrofe. Ma perché il ritiro della libido dalla realtà esterna dovrebbe essere così catastrofico se poi viene utilizzato per l’espansione dell’Io? Non è forse questo ciò che accade in varie forme di narcisismo secondario, senza che si producano catastrofi interiori – un punto che sarà ulteriormente chiarito in “Sul narcisismo: un’introduzione” di Freud (1914)?
La soluzione di Freud qui è precisa e rispetta il modello di fissazione-regressione precedentemente sviluppato:
Possiamo supporre che i paranoici abbiano portato con sé una fissazione allo stadio del narcisismo, e possiamo affermare che la lunghezza del passo indietro dall’omosessualità sublimata al narcisismo è una misura del grado di regressione caratteristico della paranoia. [1911, pag. 72, corsivo nell’originale]
La componente chiave della spiegazione di Freud può quindi essere trovata nella frase fissazione allo stadio del narcisismo. Come notato, questa è una soluzione coerente, sebbene apra punti per ulteriori esplorazioni e riflessioni, perché lo stadio narcisistico ha attributi unici abbastanza diversi da quelli di altri stadi; qui l’investimento riguarda esclusivamente l’Io, e qualsiasi alterazione a questo livello si tradurrà in un’alterazione dell’Io stesso e in una possibile esperienza catastrofica.
Di conseguenza la catastrofe interna non va considerata come l’effetto, ma piuttosto come la causa del distacco generale della libido dal mondo esterno. Quella che consideriamo la catastrofe interna in una crisi psicotica – per parafrasare Winnicott (1963a) – sarebbe in realtà la ripetizione di una catastrofe già avvenuta, e che ha continuato a incombere silenziosamente finché la struttura precaria della l’Io ha potuto resistergli.
Ciò non implica necessariamente che qualsiasi alterazione della condizione narcisistica sia catastrofica, e si può senza dubbio convenire che questo è il caso solo quando è presente una patologia psicotica. Questo punto fu ripreso implicitamente anche da Freud (1911) quando pose le seguenti domande:
Dobbiamo supporre che un distacco generale della libido dal mondo esterno sarebbe un agente sufficientemente efficace da spiegare la “fine del mondo”? Oppure l’investimento dell’Io ancora esistente non sarebbe stato sufficiente per mantenere il rapporto con il mondo esterno? [pp. 73-74]
Ma se pensiamo di essere ormai arrivati ad un punto cruciale delle formulazioni di Freud, la sua conclusione è tuttavia sorprendente: “Ma questi sono problemi che siamo ancora del tutto incapaci e incompetenti a risolvere” (1911, p. 74). In altre parole, allo stato attuale, il modello fissazione-regressione appare inadeguato a fornire un resoconto completo dei processi psicotici.
Freud tornerà più e più volte sul problema della psicosi, introducendo, soprattutto dopo il 1923, diverse modifiche alle sue teorie sui meccanismi in gioco nella paranoia e nella schizofrenia; lui e gli autori della letteratura psicoanalitica che lo hanno seguito hanno prodotto molteplici elaborazioni sull’argomento, sia che questi ultimi siano rimasti sulla strada tracciata da Freud sia che abbiano adottato un approccio più critico e divergente. In ogni caso, il problema cruciale sollevato da Freud (1911) nel suo saggio su Schreber, cioè il modello fissazione-regressione come chiave interpretativa delle psicosi, rimane sullo sfondo della maggior parte di questi contributi, anche se ampiamente e variamente riformulati, con particolare attenzione alle diverse possibili fasi in cui collocare la fissazione.
Angoscia catastrofica e formazione del soggetto
Il modello proposto da Winnicott è estremamente utile per chiarire la nozione di processi psicotici. Sottolineo l’espressione processi psicotici perché ci sono momenti in cui il contributo di Winnicott viene erroneamente interpretato come radicale proposta alternativa alla teoria freudiana nel suo complesso (Genovese 2003). Ma Winnicott (1959) è molto chiaro su questo punto:
Il termine psiconevrosi implica per l’analista che il paziente, da neonato e bambino, ha raggiunto un certo stadio dello sviluppo emotivo e che, una volta raggiunti il primato genitale e lo stadio del complesso di Edipo, si sono organizzate certe difese contro l’angoscia di castrazione. […] Laddove si trova come caratteristica importante l’angoscia di annientamento e non l’angoscia di castrazione, allora nel complesso lo psicoanalista considererà che la diagnosi del paziente non è psiconevrosi ma psicosi. [P. 130]
Come chiarisce Winnicott, si tratta di due polarità che raramente vengono identificate così distintamente nella realtà dell’esperienza clinica. E’ risaputo che, secondo Winnicott, le difese primitive strutturate nella psicosi si formano nel tentativo di proteggersi dalle anomalie ambientali in un periodo della vita molto arcaico. Per dirla più precisamente, le carenze ambientali che hanno determinato la psicosi appartengono a uno stadio di sviluppo che precede la consapevolezza dell’individuo di ciò che l’ambiente fornisce e se continuerà o meno a farlo. Nel tentativo di stabilire il momento in cui è iniziata la psicosi, Winnicott fa riferimento al grado di dipendenza dell’individuo e non alla sua pulsione pregenitale o alla zona erogena dominante.
In altre parole, la psicosi si radica in una fase così precoce della vita che non solo non è stata stabilita per il bambino l’alterità dell’oggetto come oggetto di investimento ma, proprio perché contemporaneamente al senso dell’alterità si forma il senso di sé, nemmeno il soggetto sarà ancora esistito nell’esperienza della limitazione spaziale e della continuità temporale. Qui parliamo di una fase che precede il narcisismo primario. Solo dopo aver raggiunto una sufficiente unità l’Io può essere investito narcisisticamente e solo allora può investire gli oggetti del bambino (cfr. Genovese 2003).
In questo contesto di indifferenziazione primitiva nessuna attività rappresentativa è ancora possibile. Ciò che potrebbe svilupparsi, ad esempio, è che
[…] la perdita potrebbe essere quella di alcuni aspetti della bocca, che scompaiono dal punto di vista del bambino insieme alla madre e al seno […] La stessa perdita della madre, qualche mese dopo, sarebbe una perdita dell’oggetto senza questo elemento aggiunto di una perdita di parte del soggetto. [Winnicott 1963b, p. 222]
Più avanti in questo articolo, esaminerò le implicazioni di questa ipotesi. Innanzitutto è interessante segnalare che le parole di Winnicott sembrano riecheggiare le stesse parole usate da Freud (1926) nella revisione della sua teoria dell’angoscia:
La situazione traumatica della mancanza della madre differisce in un aspetto importante dalla situazione traumatica della nascita. Alla nascita non esisteva alcun oggetto e quindi nessun oggetto poteva mancare. L’angoscia è stata l’unica reazione che si è verificata. Da allora, ripetute situazioni di soddisfacimento hanno creato nella madre un oggetto; e questo oggetto, ogni volta che il bambino avverte un bisogno, riceve un intenso investimento che potrebbe essere descritto come “desiderio”. [p. 170]
Il concetto di “situazione traumatica della nascita”, che Freud qui riprende, deriva da una teoria di Rank secondo cui questa prima separazione dalla madre è il primo trauma su cui si modellano le successive angosce di separazione. Sappiamo che Freud non era d’accordo con questa teoria; come abbiamo visto egli distingueva da un lato la separazione biologica, in cui il cambiamento di status produce angosce prive di oggetto nell’infante totalmente inconsapevole, dall’altro la separazione come perdita di un oggetto investito libidicamente. Tra queste due esperienze di separazione c’è un periodo – “la situazione ripetuta di soddisfazione” – derivante da una perdita oggettiva, cioè una perdita “non sperimentata soggettivamente”, in contrapposizione alla perdita dell’oggetto, che è invece alla base del lutto.
È questo il segmento di tempo esplorato da Winnicott e in esso possiamo collocare le prime radici della psicosi. Come rileva Green (1979), la nascita è una catastrofe nel senso teorico che oggi questo termine connota: una catastrofe superata mediante il ristabilimento di condizioni ambientali che si avvicinano il più possibile a quelle della vita intrauterina. Questo è il senso profondo e incompreso dell’holding winnicottiano, che non è altro che un “nidificazione” esterna dell’infante. La seconda nascita (ma per Freud la prima) è la perdita del seno, che permetterà la nascita dell’Io. La perdita del seno, cioè, dà accesso allo stato di Io-realtà che assicura la distinzione dall’oggetto.
Quindi, nella teoria di Winnicott, il crollo avviene come conseguenza del fallimento di questa “nidificazione” esterna del bambino e, in misura maggiore o minore, è il risultato di un blocco alla nascita del soggetto, intesa come costruzione dell’unità dell’Io. Questo tipo di catastrofe, però, non può essere considerata interna, poiché si colloca ad un livello psichico precedente a che interno ed esterno siano diventate categorie differenziate nella mente. In questo senso la fine del mondo non può essere una proiezione del crollo dell’organizzazione psichica perché l’una e l’altra sono esattamente la stessa cosa. Soprattutto, una catastrofe in questo senso non dipende dal distacco della libido dal mondo esterno ma dal distacco del bambino dalla madre che, per molte e diverse ragioni, la madre – il Sé-mondo dell’infante – realizza.
Così la perdita di “certi aspetti della bocca che scompaiono”, per usare le parole di Winnicott (1963b, p. 222), diventa poi una lacerazione irreparabile, un “buco nero” (Tustin 1981) in cui l’embrione di ciò che avrebbe dovuto svilupparsi in un Io integrato corre il rischio di essere risucchiato. E, in casi estremi, questo annientamento – considerato come una sovrapposizione di somatico e psichico – può incidere non solo sulla vita psichica, ma anche sull’intera vita futura (Genovese 1999).
Come già detto, è qui che affondano le prime radici della psicosi. Occorre comprendere che il crollo, accompagnato dall’associata angoscia di annichilimento, è la precondizione per la produzione della patologia psicotica, sebbene tale patologia si organizzerà solo più tardi, nel continuo e disperato tentativo da parte dell’Io alterato di utilizzare le proprie risorse per tenere insieme i frammenti del sé precario. E per quanto riguarda l’Io:
Esiste una differenza tra il momento in cui la patologia si organizza – generalmente al secondo e terzo anno di vita, proprio il momento che corrisponde alla prima strutturazione dell’Io – e il momento in cui si manifesta, che varia notevolmente, dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta. [Gaddini 1985a, p. 184]
Tre fasi dello sviluppo psicotico
Dal punto di vista sopra descritto, la psicosi può essere vista come il risultato di un processo in tre fasi:
1. Innanzitutto vi è il presupposto – potremmo chiamarlo l’antecedente – che altera le condizioni di formazione del soggetto in una fase primitiva della vita. L’accento si sposta allora dal problema della direzione dell’investimento libidico a quello della costituzione della soggettività – la differenziazione tra me e non-me (Winnicott 1951, 1960, 1962, 1963c) – e ciò si ripercuote sulla realizzazione della rappresentazione, che si trasforma poi nel problema della formazione della funzione rappresentazionale (Genovese 1991). La rappresentazione è la capacità di evocare la propria relazione con l’oggetto (riconosciuto come altro rispetto al soggetto) in sua assenza, e quindi di elaborare la perdita collegando l’angoscia che ne deriva a una potenziale narrazione dell’esperienza. In questo senso, è impossibile pensare a qualsiasi attività che sia pienamente rappresentativa prima della differenziazione tra soggetto e oggetto, come del resto si può dedurre dal testo di Freud. È noto che la rappresentazione, sia conscia che rimossa, matura attraverso la connessione tra esperienza sensoriale e linguaggio (Freud 1915). Prima che ciò sia possibile, la presentazione di cosa non consente il legame e l’elaborazione dell’angoscia, che viene così mobilitata come indefinita e illimitata. Potremmo addirittura dire che le angosce primitive non solo sono direttamente proporzionali all’intensità dello stimolo – interno ed esterno, essendo essi assolutamente la stessa cosa in questa fase – ma anche inversamente proporzionali alla capacità di legare quest’ultimo alla rappresentazione. Questa capacità matura insieme all’integrazione dell’Io e qualsiasi deragliamento della strutturazione dell’Io non può che compromettere la stabilizzazione della funzione rappresentazionale. In queste condizioni, il problema della lacerazione (la “scomparsa degli aspetti della bocca” o del “buco nero”) resta irrisolto e continua a drenare energie nel disperato tentativo del soggetto di trovare una via d’uscita da una situazione impossibile.
2. Nella seconda fase, la patologia si organizza e consiste nella faticosa costruzione di una soluzione – mai definitiva e sempre dispendiosa – al pericolo di annientamento e di vertigine che continuano a incombere e minacciano di risucchiare l’individuo nell’assoluto non-senso. In altre parole, la lacerazione originaria altera il processo di formazione della struttura più evoluta, condizionandola a funzionare con l’unico scopo di non crollare, a sua volta, su se stessa. Per svolgere questa funzione, l’Io mantiene a sua disposizione tutti gli ingredienti che può raccogliere dalla trama fantastica che è andato via via costruendo nel corso del tempo, secondo il modello degli stadi libidici. Con questi materiali l’Io cerca di costruire artificialmente un significato (attraverso la rappresentazione, la narrazione e gli investimenti libidici in essi), per connettere ed elaborare un’angoscia che per sua stessa natura e origine non può essere né connessa né elaborata. Qui la costruzione è diventata inefficace perché, nonostante le apparenze, in questo modello non può verificarsi alcun movimento verso il piacere. In assenza di qualsiasi coesione di sé, tutto è finalizzato alla disperata conservazione della precaria organizzazione psichica.
3. La terza fase è quella della crisi e del fallimento della soluzione apparente, quando l’organizzazione crolla e la patologia si manifesta. Allora il collegamento artificiale tra rappresentazione e angoscia senza nome corre il rischio, nonostante gli sforzi di tenerlo insieme, di disgregarsi, e la rappresentazione deve quindi trasformarsi nella realtà presente attraverso deliri e allucinazioni. Oppure, differentemente, ogni distanza dall’oggetto viene concretamente abolita nel disperato tentativo di ripristinare l’indifferenziazione primaria. Ciò si tradurrà in una ricerca compulsiva del contatto sensoriale, che sembra richiedere un oggetto, ma in realtà lo nega ed elimina.
Angoscia catastrofica e sessualizzazione
Una questione importante, quindi, ruota attorno alle strategie che l’Io alterato può attuare per preservarsi. La minaccia più devastante a questo processo viene dalla relazione con l’oggetto o, secondo Winnicott (1951; 1962), con l’oggetto oggettivamente percepito, perché ciò comporta l’esposizione alla realtà catastrofica della sua separatezza.
Naturalmente, come sottolinea Bion (1970), il vero problema non è l’oggetto in quanto tale, ma il significato della relazione instaurata con esso. La molteplicità degli oggetti rende ciascuno aggirabile in modo relativamente facile, mentre la relazione in sé può minacciare di sopraffare la consistenza del soggetto. Sappiamo che l’intuizione di ciò da parte di Bion lo portò a spostare l’attenzione dalla distruttività diretta all’oggetto attraverso attacchi invidiosi e a concentrarsi, invece, su un attacco contro la funzione di legame che gli oggetti rappresentano (Bion 1959). La rottura di questo legame è uno degli aspetti più caratteristici della difesa psicopatologica (Bion 1967) e la consapevolezza di ciò, sia in ambito teorico che clinico, ha portato a una graduale modificazione della tecnica psicoanalitica. La tecnica, infatti, si è evoluta verso una nuova attenzione al qui e ora, nonché verso una gestione molto più attenta del campo relazionale.
Le iniziali discussioni sull’importanza primaria della “interpretazione trasformativa” rivolta ai livelli psicotici della personalità sono state notevolmente arricchite da contributi che attribuiscono più valore alle costanti del setting (Bleger 1967), alla relazione analitica e soprattutto agli aspetti che favoriscono la graduale integrazione dell’Io (Winnicott 1962) e il processo di costruzione dell’apparato di pensiero e di apprendimento dall’esperienza (Bion 1962). Più recentemente, queste premesse hanno consentito anche di riconsiderare in senso positivo momenti dell’analisi che prima erano considerati ostacoli al percorso terapeutico. Ferro (1993), ad esempio, ha postulato una funzione evolutiva dell’impasse analitica come periodo necessario alla metabolizzazione dei “bastioni”, secondo la teoria di Baranger e Baranger (1969). Sottovalutare questi spazi o tempi di maturazione della struttura psichica, invece di riconoscere la loro vantaggiosa influenza sul nucleo della cura, potrebbe portare come difesa al collasso dell’Io, al rischio che “i leoni dell’inconscio negato potrebbero divorare tutto” (Ferro 2000, p. 597). Anche Ehrenberg (2000) parla dell’impasse come di una reale opportunità analitica.
Possiamo dunque considerare i rischi che l’Io deve correre nello sviluppo della sua relazione con l’alterità come un fatto generalmente acquisito. Ma meno attenzione è stata data alla possibile confusione tra l’uso strategico della sessualità da parte dell’Io per evitare il collasso, da un lato, e i problemi sessuali come fattore eziologico della patologia psicotica, dall’altro. In tempi relativamente recenti è stata avanzata la teoria secondo cui esiste una connessione tra il contenuto dei deliri psicotici e le fantasie masturbatorie dei pazienti psicotici (Freeman 1989), ma questa ipotesi rischia di confondere la somiglianza dei contenuti manifesti con una connessione causale tra i due.
Tra i pochissimi che hanno intuito questo rischio di confusione, Green (1997) affronta il problema della sessualizzazione dei conflitti che non avevano un’origine libidica. Green postula una trasposizione da una precoce dipendenza narcisistica a una dipendenza oggettuale.
Alle possibili obiezioni secondo cui la libido, autoerotica o meno, è sempre la stessa, egli risponde che ogni riferimento alla teoria classica si rivelerà inadeguato poiché il lavoro analitico mostra quanto sia facile concludere che la forza motivante dietro questo fenomeno è distruttiva piuttosto che libidica.
Molto probabilmente, questa apparente contraddizione deriva dall’equivoco che tante volte nasce quando si fa riferimento al narcisismo primario: esso, infatti, è primario solo in relazione al narcisismo secondario, e non perché costituisce il primo stadio dello sviluppo. Se si presta più attenzione a questo malinteso, la teoria classica apre la strada per andare oltre la libido narcisistica e, a mio avviso, oltre la pulsione libidica tout court. Ricordiamo il noto commento di Freud (1914), già citato, secondo il quale:
Siamo costretti a supporre che nell’individuo non possa esistere fin dall’inizio un’unità paragonabile all’Io; l’Io deve essere sviluppato […] Bisogna aggiungere qualcosa all’autoerotismo, una nuova azione psichica, per arrivare al narcisismo. [pp. 76-77]
Ciò ci permette di postulare un’area di funzionamento protomentale in cui avviene l’incubazione dell’integrazione dell’Io. In questo senso, il processo di costruzione della soggettività è una condizione necessaria che precede non solo la possibilità di investimento dell’oggetto, ma anche di investimento narcisistico, perché è l’unità dell’Io che costituisce l’oggetto della pulsione in questo secondo caso. Possiamo addirittura affermare che solo quando l’Io diventa soggetto può anche porsi come oggetto del proprio investimento.
Questo punto di vista ci permette di fornire un solido fondamento all’inseparabilità dell’accoppiamento pulsione-oggetto, come discusso da Green (2000). E, come abbiamo visto, è in questa fase pre-narcisistica che possiamo collocare l’esame di Winnicott (1963a) del tema del crollo perché, a mio avviso, l’individuo non possiede allora una riserva libidica indipendente dall’investimento pulsionale che riceve dalla madre/ambiente. Se, per qualsiasi motivo, questa acquisizione della libido oggettuale fallisce, all’infante – non ancora il soggetto – non resta altra alternativa se non quella di dissolversi nella non-integrazione.
Assumendo l’inscindibilità dell’accoppiamento oggetto-pulsione, ne conseguirebbe necessariamente che con la dimensione pre-oggetto debba esistere allo stesso tempo una dimensione pre-pulsione e pre-soggetto (Genovese 2003). L’unica istituzione in questo contesto è l’unità madre-infante, che contiene e condensa l’accoppiamento madre/pulsione-bambino/oggetto. La sessualizzazione dell’individuo è un processo che partecipa attivamente al processo più generale della sua soggettivazione. Di conseguenza l’utilizzo dell’atto sessuale per mitigare la disperazione rientra nella strategia che l’Io può adottare solo in uno stadio di sviluppo più avanzato, quando sono state raggiunte capacità più evolute che possono poi essere impiegate a sostegno del fragile nucleo originario.
L’erotomania è quindi espressione di questo tipo di strategia articolata attraverso uno spettro di possibilità e modulazioni: ad un estremo inizia con i fenomeni a cui si fa riferimento in relazione all’uso corrente del termine – solitamente non carichi di implicazioni gravemente patologiche – e prosegue fino all’altro estremo con quegli attributi presenti nel concetto psichiatrico classico, che sono direttamente associati alla psicosi. Questa strategia viene utilizzata per inventare un apparente legame libidico con l’oggetto, ma in realtà mira all’obiettivo opposto di evitarlo. Si tratta del tentativo di contrastare la minaccia dell’alterità dell’oggetto riprendendo compulsivamente il contatto sensoriale con l’oggetto-ambiente. Ciò consente l’illusione magica ma momentanea del ripristino della relazione primaria e richiede una ripetizione continua, sebbene ciò si riveli tanto inutile quanto necessario.
Il problema sta nel fatto che, sebbene il concetto di erotomania suggerisca una sorta di eccitazione materiale, in realtà si presta a considerare erroneamente un bisogno compulsivo inconscio come desiderio sessuale (o attività sessuale) – mentre questa necessità compulsiva persegue lo scopo di riproporre il bisogno infantile di contatto fisico fusionale, al fine di produrre magicamente nel corpo un senso di sé che non esiste nella mente (Gaddini 1969). L’erotizzazione del contatto non può quindi essere di tipo pulsionale, poiché la pulsione è funzione della relazione soggetto-oggetto. Il famoso erotomane Casanova, ad esempio, cercava continuamente relazioni amorose, ma solo a condizione che durassero soltanto per un giorno, per impedire l’intrusione del vero amore.
Da ciò possiamo concludere che
[…] un certo numero di presunte “storie amorose” sono in realtà incontri determinati dal bisogno di contatto. A differenza del desiderio […] il bisogno è per sua natura perentorio e indiscriminato. La realtà spinta dal bisogno non esiste come tale, ma solo in quanto serve a ciò che il bisogno esige […] Il bisogno è sentirsi amati (attraverso il contatto fisico) e questo toglie ogni possibilità di sperimentare l’amore. [Gaddini 1985b, p. 728]
Tuttavia troviamo “una capacità di seduzione ben sviluppata” per provvedere a questo bisogno. Nel complesso, «si tratta di una seduttività indiscriminata e marcatamente infantile» (Gaddini 1985b, p. 728).
In questo senso, l’erotomane sostiene l’angoscia di dissoluzione attraverso il sollievo momentaneo che il contatto corporeo e l’amore fantasticato dell’altro possono occasionalmente fornire. Inoltre, dotandosi di pseudo-investimenti libidici, l’individuo mantiene il filo che lo collega ad una realtà condivisa. Ma questa connessione ovviamente non è altro che una costruzione superficiale che di fatto sfugge a qualsiasi incontro con l’oggetto reale. Una erotomania di questo tipo, cioè una sorta di auto-cura mitigante, potrebbe essere vista come una ripetizione senza possibilità di soluzione nella memoria o nell’elaborazione.
All’estremo opposto troviamo un delirio erotomanico che comprende il tentativo di trasformare l’originaria dimensione catastrofica nella dimensione tragica, che può estendersi alla sfera della rappresentabilità e quindi alla modulazione dell’angoscia. L’Io si trova così di fronte a un compito paradossale: per la prima volta deve significare, mediante rappresentazioni, la propria angoscia catastrofica, che per sua stessa natura è irrappresentabile.
È chiaro, allora, che il concetto di significare porta con sé implicazioni del tutto diverse dalla nachträglichkeit di Freud, in quanto quest’ultima presuppone un significato originario che viene rielaborato sulla base di esperienze successive in una fase successiva. La nachträglichkeit di Freud è il vero nocciolo della dimensione tragica; in effetti la tragedia di Edipo si realizza non quando il protagonista uccide Laio o va a letto con Giocasta, ma quando, scoprendo in seguito che Laio è suo padre e Giocasta sua madre, risignifica l’esperienza come parricidio e incesto. È solo a questo punto che entrano in gioco l’orrore, la colpa e il conflitto. La rimozione/cecità è una possibile “soluzione” in quanto rende tutto irrappresentabile alla coscienza. Qui la mancata rappresentazione è la conseguenza tragica di una soluzione che è tragica anche perché, pur essendo inconscio, il contenuto rimosso resta potenzialmente narrabile e la quantità di energia necessaria per mantenerlo in una condizione di irrappresentabilità è enorme. La dimensione tragica e quella nevrotica sono quindi intimamente connesse. Nei casi di psicosi di cui stiamo discutendo, invece, l’irrappresentabilità è la genesi del problema, che non implica necessariamente conflitto o rimozione intrapsichica. L’irrappresentabilità consiste semplicemente nel fatto che non esistono ancora le condizioni affinché la funzione rappresentazionale possa trasformare i dati grezzi in esperienza, e quindi la situazione non può che essere catastrofica e accompagnata da un’angoscia senza nome. La tragedia è impossibile perché la narrazione è impossibile.
Anche qui, naturalmente, molte energie vengono impiegate, ma per il motivo opposto, che consiste nel tentativo di collegare l’angoscia senza nome a una qualche forma di narrazione tragica mutuata dall’esperienza successiva – a partire dalla seconda fase dello sviluppo della patologia. La funzione rappresentazionale è quindi impegnata nel compito anomalo di costruire artificialmente un senso per spiegare un’angoscia che è devastante proprio perché priva di senso. Questa è una conseguenza di eventi arcaici accaduti prima che il soggetto si formasse, e quindi non sono mai stati vissuti come esperienza soggettiva. Ciò che accade è che si inventa una sorta di protesi, una protesi di senso per coprire il buco, mascherando la mutilazione in un modo che può avere una certa credibilità, ma senza sanarla; ma, come per tutte le protesi, anche questa è rigida, nel senso che non può possedere sufficiente plasticità per resistere a tutti gli assalti della realtà, sia esterna che interna. In casi estremi, quando il rischio di catastrofe è imminente, la protesi deve intensificare i suoi sforzi e, come accennato in precedenza, deve trovare senso nel tessuto delle rappresentazioni deliranti o nelle allucinazioni (Genovese 1991, 2003).
Affinché questa operazione produca risultati efficaci, il materiale tragico (costruito artificialmente), o il contenuto del delirio, necessitano di componenti amorose perché lo scopo più importante è raggiungere l’elemento salvifico nascosto dietro gli pseudo-investimenti libidici – l’unica e sola possibile alternativa alla dissoluzione nel vuoto. Nella psicosi si forma quindi uno stretto rapporto tra Eros e disperazione, un rapporto speciale, l’inverso del cosiddetto funzionamento normale o nevrotico.
Schematicamente potremmo dire che nell’individuo nevrotico o relativamente “sano di mente”, anche quando non si trova traccia di sofferenza sessuale ad un livello manifesto, la sofferenza è sempre un’espressione del sessuale. La rimozione, con le molteplici possibili formazioni sintomatiche, è la soluzione più o meno patologica e la posta in gioco è il piacere.
Nello psicotico, invece, ciò che sul piano manifesto appare esplicitamente legato alla sessualità è divenuto espressione di un tentativo variamente costruito di uscire dalla disperazione. Qui la soluzione è l’azione sessuale o l’allucinazione e l’unico obiettivo è il sollievo.
Possiamo in effetti presupporre una continuità funzionale tra la compulsione sessuale e la trama di una fantasia delirante, costituita da questo stesso tentativo di utilizzare la sessualità per soddisfare il bisogno dell’Io di evitare la disgregazione nella disperazione. Può prevalere il bisogno apparentemente più diretto del contatto fisico, ma permane una condizione di equilibrio difficile da mantenere tra ricerca di senso ed evitamento dell’oggetto.
Nella situazione clinica, i processi che abbiamo descritto appaiono molto raramente nelle forme immediatamente riconoscibili di queste due polarità. Nella maggior parte dei casi essi sono intrecciati o collocati a diversi livelli dell’organizzazione psichica. Alcune manifestazioni francamente perverse, ad esempio, potrebbero forse essere spiegate alla luce di queste considerazioni.
Presentazione clinica: la disperazione di Mirko
Mirko ha trentaquattro anni. Da tempo ha quasi rinunciato agli studi universitari, senza però decidere di abbandonarli del tutto. Vive con i suoi genitori e non ha un lavoro né una relazione sentimentale. Legge voracemente, soprattutto libri di egittologia, che è la sua passione, e mantiene una regolare corrispondenza con amici che vivono in altre città.
Fin dall’inizio, il suo rapporto con l’analista è stato caratterizzato da una pressione insistente per risolvere quella che egli definisce “una disperazione immensa e ormai insopportabile”. Parla di questa disperazione, con insistenza e angoscia, come qualcosa di concreto e devastante, ma allo stesso tempo del tutto indefinito. Mostra un marcato risentimento verso i membri della famiglia, che non sembravano mai rendersi conto che, mentre altri adolescenti vivevano le loro prime esperienze sessuali, lui rimaneva esclusivamente assorbito dalle sue letture e totalmente all’oscuro di tutto ciò che riguardava la sessualità. Adesso, da adulto, è cosciente di un vuoto incolmabile nella sua storia e ha un disperato bisogno di risolvere la questione, ma non ha idea di come gestirla perché non ne sa nulla.
La prima mezz’ora di ogni seduta è dedicata alla ripetizione di questo argomento, sempre con le stesse parole. Mirko si agita sul divano, urlando, a volte piangendo, ma esprimendo sempre la sua sofferenza con feroce risentimento. La sua comunicazione non contiene libere associazioni o narrazioni estemporanee, ma solo assiomi sulla sua vita; la sua dilagante auto-narrazione non lascia spazio alla formazione di costruzioni alternative. Reagisce furiosamente ai miei silenzi, accusandomi di indifferenza verso la sua disperazione (“Non le salgono le pulsazioni quando le dico quanto soffro terribilmente?!”). Ma ogni volta che provo ad entrare nel suo discorso, di solito in modo estremamente cauto ed esplorativo, lui mi interrompe altrettanto arrabbiato, rimproverandomi di non vederlo veramente e di usare un modello precostituito per tenerlo ingabbiato. Da questo momento in poi, ad ogni frase che pronuncio mi interrompe, etichettando le mie parole come un maldestro tentativo di difendermi perché “mi ha colto di sorpresa” e, per dimostrarlo, accenna a qualche tono particolare che nota nella mia voce, o a un certo movimento che faccio quando cambio posizione sulla mia sedia che secondo lui mi tradisce.
Alcuni aspetti del suo arrabbiarsi costituiscono un vero e proprio attacco al legame nel senso illustrato da Bion (1959); ma alla luce di quanto si è sviluppato in seguito, possiamo dire che forse questa dinamica potrebbe essere interpretata anche nei termini di una metafora più specifica.
In effetti, è diventato gradualmente chiaro che questa dinamica relazionale non poteva essere spiegata soltanto come espressione di un attacco al legame. La ripetizione continua ed identica di Mirko certamente indica anche una sorta di processo inconscio che non è esclusivamente finalizzato ad impedire l’irruzione dell’analista. L’attenzione meticolosa che presta ai miei movimenti fisici, quasi impercettibili, e al minimo cambiamento nel tono della mia voce, implica tanto sospettosità quanto attrazione.
Ad ogni modo, trascorrono mesi prima che io offra un’interpretazione a Mirko. Spesso, anche se con molta attenzione e senza molto successo, attiro la sua attenzione sulla ripetizione di questa dinamica. Aspetto che dica qualcosa che mi permetta di usare le sue stesse parole per esprimere le sue emozioni e le sue angosce. Il mio controtransfert comprende intensi sentimenti di impotenza, alternati a sentimenti altrettanto intensi di pietà. Alla fine di ogni seduta Mirko chiede di andare in bagno, dove trascorre parecchio tempo; dopo un po’ che questo accade mi capita di pensare che potrebbe andare lì per masturbarsi.
Dopo circa un anno, tra incerte aperture e fugaci allusioni, tutto viene fuori: Mirko ha un bisogno irresistibile di masturbarsi, sia di giorno che di notte, fino a quattro o cinque volte nelle ventiquattr’ore, se ci riesce. Ma la cosa veramente interessante per il nostro argomento attuale è la sua fantasia masturbatoria, che con variazioni marginali è sempre la stessa. La scena è ambientata nell’antico Egitto, con i suoi paesaggi e incorporandone i costumi. Il paziente siede su un trono su una sedia dallo schienale alto, e ai suoi piedi striscia un giovane schiavo maschio in catene al quale dà ordini: “fai questo, fai quello”. Mirko trae eccitazione dall’osservare ogni dettaglio del corpo dello schiavo: il movimento dei muscoli delle sue braccia mentre lavora, oppure le vene del suo collo o il sudore della sua fronte. Lo schiavo è esausto, sudato, ma – cosa più importante – sottomesso. Nella fantasia lo schiavo può assumere le sembianze di un ragazzo che Mirko conosce e che lavora al panificio, oppure quello del benzinaio, o di altri ragazzi con lavori umili che nella vita reale lo gettano in uno stato di elevata eccitazione mista ad acuta sofferenza. È qui che la fantasia si ferma, poiché non è necessaria alcuna ulteriore elaborazione e non esita mai in nessuna forma di atto sessuale.
A questo punto il quadro psichico sembra più chiaro e sembra che io possa ora tentare un’interpretazione. L’ipotesi che introduco con cautela è che, in analisi, Mirko tende a instaurare una dinamica relazionale dello stesso tipo, riducendomi in una condizione di impotenza, mentre tiene d’occhio i miei minimi movimenti. Questo suggerimento lo fa infuriare, ma ne sembra colpito. Condividendo infatti con l’analista la sua segreta fantasia masturbatoria, Mirko si è esposto al rischio di fidarsi di lui, e questa è una delle fonti fondamentali della sua disperazione. Possiamo rintracciare l’espressione di questa dinamica nei seguenti frammenti di dialogo, avvenuti nel corso del secondo anno di analisi; episodicamente, e solo per pochi minuti alla volta, riusciva ad allontanarsi dalle sue irremovibili ricostruzioni autobiografiche giusto il tempo necessario per recuperare un flash della sua infanzia.
Paziente: Quando avevo due o tre anni ed entrambi i miei genitori lavoravano, mi lasciavano nella grande casa di alcune mie zie. Ricordo che le stanze erano sempre molto fredde e buie. Ricordo che in giardino vivevano dei gattini rognosi; le mie zie li avevano portati a casa per “salvarli”, per poi abbandonarli completamente dopo un po’. Mi sono sentito molto dispiaciuto per quei gattini. . .
Analista: I gattini sono stati lasciati soli, fuori al freddo e al buio, come ere lei, lontano dal calore dei suoi genitori. Deve essere stato molto difficile fidarsi di qualcuno che ti convince ad affidarti a lui e poi ti abbandona in quel modo.
Questa è stata quasi la prima volta che Mirko non ha reagito alle mie parole attaccandomi, ma è rimasto in silenzio sul divano, riflettendoci, fino alla fine della seduta. Il giorno dopo, però, nel momento in cui si sdraiò, esplose di rabbia intensa.
Paziente: [urlando] Ieri è stata una completa perdita di tempo! Lei si è rifiutato di dire una sola parola per farmi superare la mia disperazione. Continuava a blaterare sui gattini!
Analista: Forse è arrabbiato con se stesso perché si è lasciato andare per un po’: ha paura al pensiero che potrebbe arrivare a fidarsi di me e correre il rischio di essere abbandonato.
Paziente: [ancora urlando] Certo perchè la girerebbe come vuoi lei! Scegliendo tra le cose che dico esattamente quello che fa per lei!
Analista: Forse vorrebbe rendermi schiavo e incatenarmi. Non è così?
Paziente: Suppongo che lei abbia ragione!
Analista: Questa idea potrebbe essere collegata alla sua fantasia masturbatoria. L’angoscia di dover dipendere dalla mia “scelta tra le cose che dice” può essere affrontata solo dopo che mi ha incatenato come uno schiavo e mi guarda sudare, impotente.
Quest’ultima mia affermazione non era pertinente solo al materiale del paziente, ha avuto anche una risonanza emotiva per me perché mi sentivo davvero messo alla prova. Un attimo prima mi ero sorpreso a pensare: “Mi sta facendo sudare”. E anche Mirko sembrò colpito dalla mia osservazione. Per un po’ non disse nulla. Alla fine reagì accusandomi nuovamente di perdere tempo e di “rifugiarmi nella psicoanalisi”.
Qualche settimana dopo mi raccontò il suo primo sogno (“ma solo perché so che a voi analisti interessano i sogni”, disse sarcasticamente). Nel sogno, uno scuolabus carico di bambini percorre una strada sull’orlo di un precipizio. L’autista fa del suo meglio per mantenere una rotta costante, ma alcuni bambini si rendono conto che dovranno prendere il comando. Spingono da parte l’autista e prendono il volante.
Certo, il fatto che Mirko sia finalmente capace di raccontarmi un sogno è di per sé un importante segnale di cambiamento. Innanzitutto, sotto forma di rappresentazione onirica, era la prima volta che raccontava qualcosa, che poteva comunicare qualcosa del suo mondo interno. Ciò potrebbe significare che, nonostante la laboriosità del procedimento, il lavoro analitico stava gradualmente incidendo sul processo di integrazione dell’Io, sulla sua funzione, e in particolare sulla sua capacità di rivelare – attraverso un’evoluta attività di rappresentazione – il significato delle sue angosce primitive e delle manovre difensive che le accompagnavano.
In secondo luogo, il contenuto del sogno che esprimeva il timore di Mirko di affidare il suo fragile sé all’inaffidabile analista/autista dell’autobus, allo stesso tempo rivelava il suo bisogno latente di fare esattamente questo. C’erano anche indicazioni di qualcosa che si stava evolvendo nel transfert. Ovviamente, il conflitto tra il suo bisogno e la sua angoscia di mettersi alla mercé di qualcun altro non potrebbe manifestarsi né mai essere condiviso con me, perché ciò lo catapulterebbe nella spaventosa situazione di dovermi confidare l’impossibilità della situazione – oppure, di converso, lo metterebbe nella situazione di stabilire un rapporto reale con l’oggetto, cioè proprio ciò che lo terrorizzava.
Così ho aspettato invano che Mirko si lasciasse andare fino al punto da poter fare delle libere associazioni sul sogno. Lui stesso trovava inconcepibile l’aver creato questo buco nella sua diga difensiva. Rimase in seduta immobile, pietrificato, evidentemente spaventato da ciò che aveva fatto: mi aveva raccontato il suo sogno! Ora probabilmente stava lottando per inventare un modo per correggere la situazione e prendere il volante dell’autobus anche se, come i bambini nel suo sogno, sapeva di non poter guidare.
E in effetti il mio tentativo di collegare il suo sogno a una seduta di qualche settimana prima (quando l’autista/analista dell’autobus aveva guidato arbitrariamente l’analisi, esponendolo al rischio della dipendenza e quindi a un tuffo nella sua angoscia catastrofica) era saldamente contestata da Mirko, che aveva deciso di riprendere il controllo dell’analisi.
Paziente: [Urla facendo una smorfia come se soffrisse.] Ciò che mi interessa è la mia sessualità spasmodica, le fantasie masturbatorie che non riesco mai a realizzare. Il numero di volte in cui ho bisogno di masturbarmi mi sta esaurendo. Questo è ciò di cui dobbiamo parlare. Non me ne frega niente dei sogni!
Analista: La sessualità di cui parla non sembra darle alcun piacere. La vive come un segno di disperazione.
Paziente: Beh, questo lo so, no? Non ho bisogno che lei me lo dica! [Qui penso tra me che il suo mugolio si sentiva fin giù per le scale dell’edificio.] Quello che non so è come uscirne!
Analista: Lei si sente intrappolato in una situazione dalla quale non c’è via d’uscita. Non può fidarsi dell’autista dell’autobus perché ha paura di cadere dal dirupo; ma una volta che si mette al volante, non sa dove andare da lì. Nella sua condizione di angoscia, tutto ciò che può fare è incatenare l’autista/analista e controllare la sua angoscia attraverso l’eccitazione di questa manovra. La masturbazione potrebbe avere qualcosa a che fare con questo tipo di eccitazione, non crede?
A questo punto Mirko si siede di colpo sul divano, e poi la sua smorfia di dolore lascia il posto a un singhiozzo disperato.
La profondità dell’abisso in cui quest’uomo aveva tanta paura di cadere divenne più chiara alcuni mesi dopo. Ha potuto raccontare un episodio di quando era molto piccolo, di cui spesso i suoi genitori gli avevano parlato. Un’anziana zia lo teneva tra le braccia quando improvvisamente ebbe un ictus e morì sul colpo. Si trattava ovviamente di un esempio particolarmente rappresentativo di un evento traumatico per il bambino, che lo esponeva a un’esperienza di discontinuità catastrofica, per sua natura non rappresentabile e quindi non elaborabile: il “cadere per sempre”, per dirla con Winnicott (1962, p. 58; 1963a, p. 90).
I livelli psichici coinvolti in questo episodio, come quelli dei progressivi sviluppi dell’analisi, furono naturalmente molti e diversi. Mirko adesso è ancora in analisi; ci stiamo avvicinando al nostro quinto anno di lavoro. Sono successe molte cose, soprattutto nella sua vita sociale (ora vive da solo e ha un lavoro part-time), anche se il nucleo della sua disperazione non è stato scalfito. Mi limiterò qui, tuttavia, a ritornare sugli aspetti del caso su cui si concentra il presente contributo.
La descrizione che Mirko fa della sua fantasia masturbatoria ci permette di comprendere il suo rapporto con l’analista in seduta. Possiamo ora cominciare ad apprezzare il senso che il paziente ha dato alla sua angoscia senza nome, attraverso l’azione immaginata. Come abbiamo visto, egli è costantemente in preda ad una disperazione intensa e indefinibile, come se fosse sempre sul punto di cadere in un precipizio. La sua modalità di interazione permette di ipotizzare un’esperienza di relazione primaria caratterizzata da due estremi complementari, entrambi catastrofici: da un lato, aveva sperimentato una sfiducia nei confronti di una madre distante e non sufficientemente “preoccupata” nei suoi confronti; dall’altro, aveva vissuto l’esperienza di una madre che si poneva come una sorta di altro prematuro, che costringeva i desideri del bambino a conquistare i propri, ostacolando così la sua progressiva acquisizione di un senso di continuità di sé a partire da quella corporea.
L’unica reazione emotiva possibile a una situazione del genere è un misto di angoscia catastrofica e rabbia impotente, espressa attraverso difese di tipo persecutorio (la matrice originaria della fantasia masturbatoria molto probabilmente collocava Mirko nel ruolo dello schiavo impotente). Ma, soprattutto, era assolutamente necessario che Mirko reprimesse ogni esperienza che potesse esporlo a una definizione di sé (ad esempio, non era possibile terminare gli studi o sostenere l’esame per la patente) ed entrare effettivamente in rapporto con l’alterità dell’oggetto (ad esempio, lavorando sulla sua relazione con l’analista).
Per sopravvivere agli abissi della disperazione, un paziente del genere deve affrontare la drammatizzazione della dinamica padrone-servo, invertendola ed erotizzandola. Il paziente trasforma così l’impotenza in onnipotenza e possiede l’oggetto, in modo che diventi soggetto-oggetto (che è una delle ragioni della natura omosessuale della fantasia di Mirko). L’oggetto incatena così il paziente, lo osserva da vicino come fa l’analista e, masturbandosi, il paziente trova finalmente un momentaneo sollievo, come probabilmente ha fatto Mirko dopo le sue sedute analitiche.
Osservazioni conclusive
Il riferimento ad un’angoscia senza nome, a un “cadere per sempre” e a una disperazione intensa, indefinibile, è fondamentale per posizionare il caso di Mirko nel quadro teorico in discussione. Se non lo facciamo, ci troveremo ad affrontare l’argomento come è già stato ampiamente trattato, in vari modi, nella letteratura psicoanalitica. Molti autori, infatti, hanno descritto un possibile uso difensivo della sessualità, particolarmente rispetto alle perversioni (vedi, ad esempio, Bak 1953; Eidelberg 1945; Greenacre 1960, 1968, 1969; Khan 1965, 1969; Kohut 1977). Nello specifico, il concetto di sessualizzazione è stato affrontato in relazione ai disturbi narcisistici della personalità (Goldberg 1975; Green 1979, 1997, 2000; Kohut 1971, 1977; Stolorow 1975a, 1975b).
In ogni caso, come segnala Coen (1981), questi contributi rivelano un uso eccessivamente diffuso e generico del concetto di sessualizzazione; Coen nota che molti autori che usano questo termine lo fanno in riferimento ad almeno tre diversi livelli di fenomeni. Questi fenomeni iniziano con la pura descrizione di un generico comportamento non sessuale che poi si trasforma in qualcosa di sessuale o che diventa qualcosa di simile al sessuale, per poi individuare la presenza di un eccesso di energia libidica che può essere associata ad un processo mentale, ed infine giungere ad una difesa attraverso la quale la patologia narcisistica si traduce in un comportamento perverso.
L’ipotesi che qui presento descrive invece una manovra psichica ben precisa, che consiste nell’utilizzo della sessualizzazione come artefatto e come soluzione psicotica che attinge a successivi periodi di sviluppo, con un aspetto dalla duplice finalità, orientato in senso opposto alla vera pulsione sessuale: cioè verso l’evitamento dell’alterità dell’oggetto attraverso la costruzione di una trama narrabile nella fantasia. Questo è il motivo per cui, paradossalmente, l’uso della sessualità autoerotica da parte di Mirko somiglia all’uso che ne faceva Casanova nelle sue sfrenate relazioni amorose. In entrambi i casi l’aspetto sessuale è sempre manifesto (anche perché sembra inserire l’individuo nella trama reale della vita, o almeno della fantasia), mentre ciò a cui contribuisce è un evitamento dell’alterità reale dell’oggetto; e ciò che maschera è la disperazione causata dal rischio sempre presente di una disgregazione irrappresentabile.
Quindi, per riprendere un filo iniziale della mia argomentazione, non è affatto sorprendente trovare Schreber (1903; vedi anche Freud [1911]) che costruisce il suo delirio in modo tale che l’oggetto non possa materializzarsi nella realtà concreta, proprio nel momento in cui lui sta scivolando nell’abisso. Inoltre, il delirio erotomanico assolve alla funzione paradossale di tessere connessioni con la realtà rappresentabile e, in questo senso, di soddisfare il bisogno di condivisione; ma lo fa solo quando il baratro si apre al di sotto, sulla spinta del terrore dell’Io di essere risucchiato nel “buco nero” originale. Se ogni cambiamento importante nello sviluppo dell’individuo ha sempre un carattere catastrofico nel senso teorico menzionato da Green (1979, 1997, 2000) allora, nel caso di un’organizzazione psichica precaria, lo stesso cambiamento può avere un effetto clinicamente devastante e minacciare la coesione dell’Io stesso. Sembra che raramente sia stata prestata attenzione a questo aspetto del problema. Nella sua autobiografia Schreber (1903) collega esplicitamente la sua prima crisi psicotica con la candidatura al Reichstag, e la seconda con la sua promozione a presidente della Corte d’Appello; naturalmente, nel discutere questo, Freud non si discosta dai dati biografici ma focalizza l’attenzione sul senso che i dati assumono nel contenuto drammatico del delirio e non sul potenziale catastrofico per l’Io portato dal cambiamento del Sé.
Il contenuto della fantasia delirante è certamente importante e richiede un’analisi approfondita dei suoi vari aspetti. Ma quello che qui voglio sottolineare è che il contenuto è sempre un tentativo – forse “folle”, ma non trascurabile – di costruire artificialmente il senso attraverso una trama tragica condivisibile (anche se non condivisa), narrabile, che di fatto trasforma la catastrofe in dolore, persecuzione, rabbia, colpa, gelosia, lutto. In ogni caso, la rappresentazione tragica conduce l’individuo in un universo libidico di affetti e di memoria, mentre la catastrofe in sé non è altro che dissoluzione nel vuoto e terrore senza nome.
Freud (1911) intuì il motivo salvifico di tale fantasia delirante quando, nei confronti di Schreber, attirò l’attenzione sul fatto che “la formazione delirante, che consideriamo il prodotto patologico, è in realtà un tentativo di guarigione, un processo di ricostruzione” (p. 71). Ciò che va ben compreso, però, è che l’apparente fallimento di questo tentativo è dovuto al fatto che la guarigione e la ricostruzione non sono i veri obiettivi in gioco. Lo scopo è piuttosto la sopravvivenza stessa dell’Io e, rispetto a questo, il tentativo posto in essere come soluzione patologica può essere considerato fondamentalmente riuscito.
Celestino Genovese è stato Psicoanalista, Membro Ordinario SPI-IPA, Socio del CNP
Darwin Mervoglino, Psicoanalista, Membro Associato SPI-IPA, Socio del CNP
References
Abraham, K. (1908). Die psychosexuellen Differenzen der Hysterie und der Dementia praecox. Zentbl. Nervenheilk. Psychiat.,
19:521-533.
Bak, R. (1953). Fetishism. J. Amer. Psychoanal. Assn., 1:285-298.
Baranger, M., Baranger, W. (1969). Problemas del campo analítico. Buenos Aires, Argentina: Kargiemann.
Bion, W. R. (1959). Attacks on linking. In Second Thoughts. London: Heinemann, 1967.
Bion, W. R. (1962). Learning from Experience. London: Heinemann.
Bion, W. R. (1967). Second Thoughts. London: Heinemann.
Bion, W. R. (1970). Attention and Interpretation. London: Tavistock.
Bleger, J. (1967). Psycho-analysis of the psycho-analytic frame. Int. J. Psychoanal., 48:511-519.
Clérambault, G. G. (1921). Érotomanie pure, érotomanie associée. In Oeuvres psychiatriques. Paris: Frénésie Editions,
336-347.
Coen, S. J. (1981). Sexualization as a predominant mode of defense. J. Amer. Psychoanal. Assn., 29:893-920.
Ehrenberg, D. B. (2000). Potential impasse as analytic opportunity. Contemp. Psychoanal., 36:573-586.
Eidelberg, L. (1945). A contribution to the study of the masturbation fantasy. Int. J. Psychoanal., 26:127-137.
Ferro, A. (1993). The impasse within a theory of the analytic field: possible vertices of observation. Int. J. Psychoanal.,
74:917-929.
Ferro, A. (2000). On James Herzog’s “Blood and Love.” Int. J. Psychoanal., 81:595-597.
Freeman, T. (1989). A sexual theory of persecutory delusions. Int. J. Psychoanal., 70:685-692.
Freud, S. (1895). Draft H. Paranoia. S. E., 1.
Freud, S. (1896a). Draft K. The neuroses of defence (a Christmas fairy tale). S. E., 1.
Freud, S. (1896b). Further remarks on the neuro-psychoses of defence. S. E.,3.
Freud, S. (1905). Three Essays on the Theory of Sexuality. S. E., 7.
Freud, S. (1908). Delusions and dreams in Jensen’s “Gradiva” S. E., 9.
Freud, S. (1911). Psycho-analytic notes on an autobiographical account of a case of paranoia (dementia paranoides). S. E., 12.
Freud, S. (1914). On narcissism: an introduction. S. E., 14.
Freud, S. (1915). The unconscious. S. E., 14.
Freud, S. (1926). Inhibitions, Symptoms and Anxiety. S. E., 20.
Gaddini, E. (1969). On imitation. In A Psychoanalytic Theory of Infantile Experience. London/New York: Tavistock/Routledge,
1992, pp. 18-34.
Gaddini, E. (1985a). The mask and the circle. In A Psychoanalytic Theory of Infantile Experience. London/New York: Tavistock/
Routledge, 1992, pp. 177-185.
Gaddini, E. (1985b). La nascita, la crescita. In Scritti, 1953-1985. Milano, Italy: R. Cortina, 1989, pp. 702-730.
Genovese, C. (1991). The problem of representability. In Psychoanalysis and Development: Representations and Narratives, ed.
M. Ammaniti & D. N. Stern. New York/London: New York Univ. Press, 1994, pp. 175-186.
Genovese, C. (1999). Vertigine e non-senso nella depressione psicotica. In Il piacere offuscato, ed. A. Racalbuto & E. Ferruzza.
Roma, Italy: Borla, 1999, pp. 37-59.
Genovese, C. (2003). En deçà ou en dessous du sexuel. Penser/Rêver, 3:207-224.
Goldberg, A. (1975). A fresh look at perverse behavior. Int. J. Psychoanal., 56:335-342.
Green, A. (1979). L’angoisse et le narcissisme. In Narcissisme de vie, narcissisme de mort. Paris: Minuit, 1983.
Green, A. (1997). Les chaînes d’Eros. Paris: Odile Jacob.
Green, A. (2000). The intrapsychic and intersubjective in psychoanalysis. Psychoanal. Q., 69:1-39.
Greenacre, P. (1960). Regression and fixation: considerations concerning the development of the ego. In Emotional Growth,
Vol. I. New York: Int. Univ. Press, 1971.
Greenacre, P. (1968). Perversions: general considerations regarding their genetic and dynamic background. In Emotional
Growth, Vol. I. New York: Int. Univ. Press, 1971.
Greenacre, P. (1969). The fetish and the transitional object. In Emotional Growth, Vol. I. New York: Int. Univ. Press, 1971.
Jones, E. (1953). The Life and Work of Sigmund Freud. New York: Basic Books.
Jung, C. G. (1907). Uber die Psychologie der Dementia praecox: ein Versuch. Halle, Germany: Marhold.
Khan, M. M. R. (1965). Foreskin fetishism and its relation to ego pathology in a male homosexual. Int. J. Psychoanal.,
46:64-80.
Khan, M. M. R. (1969). Role of the “collated internal object” in perversion-formations. Int. J. Psychoanal., 50:555-565.
Kohut, H. (1971). The Analysis of the Self. New York: Int. Univ. Press.
138X. Eros and psychotic despair
Kohut, H. (1977). The Restoration of the Self. New York: Int. Univ. Press.
Lacan, J. (1932). Le cas Aimée. In De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Paris: Sueil, 1975.
Schreber, D. P. (1903). Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Leipzig, Germany: O. Mutze.
Smith, H. F. (2003). Analysis of transference: a North American perspective. Int. J. Psychoanal., 84:117-141.
Stolorow, R. (1975a). Addendum to a partial analysis of a perversion involving bugs. Int. J. Psychoanal., 56:361-364.
Stolorow, R. (1975b). The narcissistic function of masochism (and sadism). Int. J. Psychoanal., 56:441-448.
Terrier, F. (1967). De l’érotomanie. In Le désir et la perversion. Paris: Editions du Seuil.
Tustin, F. (1981). Autistic States in Children. London: Routledge/Kegan Paul.
Winnicott, D. W. (1951). Transitional object and transitional phenomena. In Through Paediatrics to Psycho-Analysis. London:
Hogarth/Inst. Psychoanal., 1975.
Winnicott, D. W. (1959). Classification: is there a psycho-analytic contribution to psychiatric classification? In The Matura-
tional Processes and the Facilitating Environment. London: Hogarth, 1965.
Winnicott, D. W. (1960). The theory of the parent–infant relationship. In The Maturational Processes and the Facilitating
Environment. London: Hogarth, 1965.
Winnicott, D. W. (1962). Ego integration in child development. In The Maturational Processes and the Facilitating Environ-
ment. London: Hogarth, 1965.
Winnicott, D. W. (1963a). Fear of breakdown. In Psycho-Analytic Explorations, ed. C. Winnicott, R. Shepherd & M. Davis.
London: Karnac, 1989.
Winnicott, D. W. (1963b). The mentally ill in your caseload. In The Maturational Processes and the Facilitating Environment.
London: Hogarth, 1965.
Winnicott, D. W. (1963c). From dependence towards independence in the development of the individual. In The Matura-
tional Processes and the Facilitating Environment. London: Hogarth, 1965.