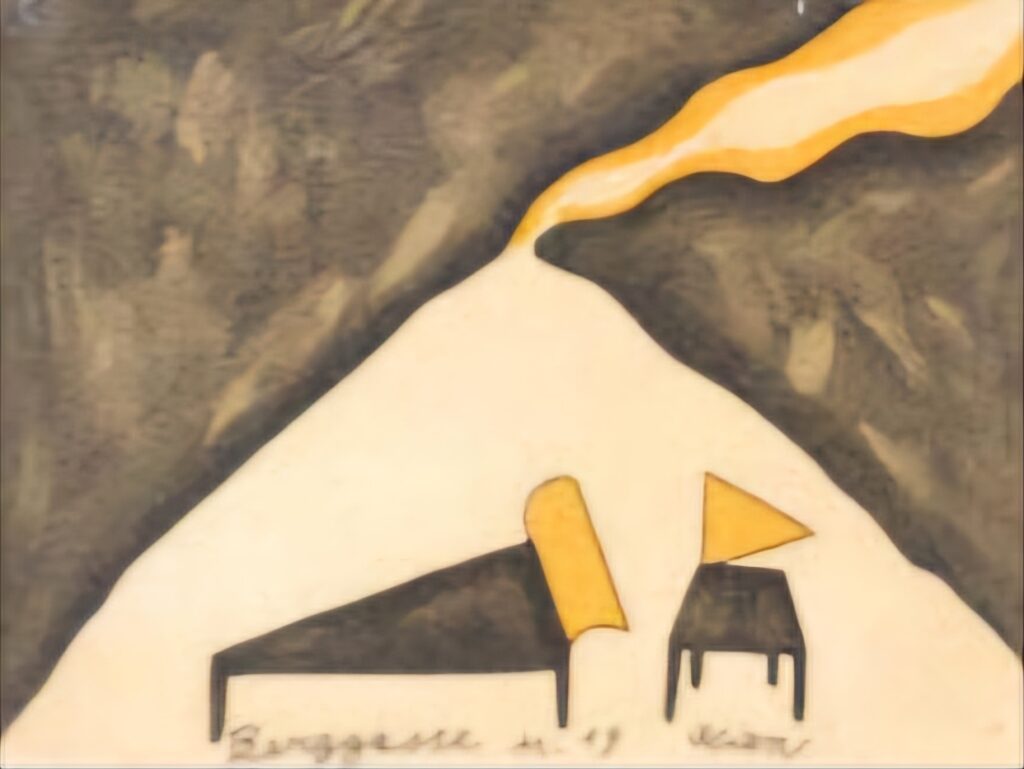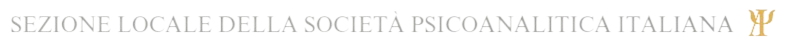L’inquietante intimità. Legàmi e fratture nei transiti migratori
Report di Anna Padula*
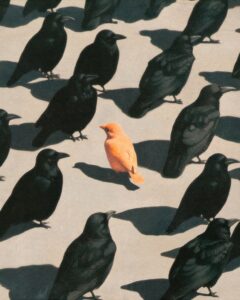
Report di Nodi in Psicoanalisi del 23 Giugno 2025 – Napoli
“L’inquietante intimità. Legami e fratture nei transiti migratori” è il titolo del ricco volume in cui Virginia De Micco, psichiatra e psicoanalista, Ordinario SPI, ha raccolto oltre un ventennio di studi e riflessioni sulla migrazione. Il vertice psicoanalitico, dal quale questo viaggio sembra partire – lungo, si potrebbe dire, come quello di tanti migranti – si combina, in una ben dosata polifonia, ad altri vertici. In occasione della giornata di studio organizzata, il 21 giugno, presso il Centro Napoletano di Psicoanalisi, quattro relatori sono stati chiamati a dialogare tra di loro: Fausta Ferraro, Sarantis Thanopulos, Luca Di Sciullo e Valerio Petrarca. Ne è risultato un fecondo incontro tra culture e saperi diversi, che hanno saputo integrarsi pur mantenendo intatte le proprie specifiche identità: una ben riuscita realizzazione di ciò che Virginia De Micco ha indicato come spazi per le differenze.
Metodo è il punto dal quale parte Fausta Ferraro. La questione metodologica è culturale, anche quando prende le mosse dal dato biologico. Come scrive De Micco, “l’essere umano è destinato dalla sua stessa biologia alla socialità”, e la sua Hilflosigkeit lo rende inevitabilmente dipendente dalla cultura. Cultura e Metodo costituiscono, dunque, un portato ambientale che entra in tensione non solo con la Natura, ma anche con l’Identità. È su questo sfondo che psicoanalisi e antropologia si sono più volte incontrate: nel tentativo di individuare universali invarianti, il dialogo si è spesso concentrato su un piano metodologico. La prima parte del volume, “Dalla ricerca etnografica alla psicoanalisi”, esplora proprio la possibile complementarità tra i due saperi, che Ferraro immagina congiunti dall’avverbio attraverso. L’alterità culturale è luogo privilegiato per l’indagine dell’Inconscio, dato che ogni cultura struttura un proprio sistema ortogonale entro cui leggere e interpretare la clinica. Per questo, bisognerebbe rinunciare alla pretesa di individuare un Inconscio Globale, e al “colonialismo occidentale della clinica”. Ferraro si sofferma anche sulla terza parte del volume, nel quale De Micco dedica un denso capitolo (“Dall’angoscia dell’ignoto al metodo dello straniero”) al metodo di lavoro di supervisione psicoanalitica con gli operatori nei centri di accoglienza: i bambini migranti possono interiorizzare l’alterità culturale in forme che appaiono iper-adattive oppure possono difensivamente rigettare la nuova cultura, portando su di sé, come cucita nell’identità, una seconda pelle difensiva di strati culturali imposti dalle origini.
Identità. Sarantis Thanopulos guarda agli scontri tra civiltà diverse, che oppongono l’Occidente all’“Altro Mondo”. Le migrazioni assumono una natura patologica poiché è proprio l’Occidente a creare le condizioni che le alimentano, attraverso la precarietà climatica, economica e politica. Anche l’ambiente di accoglienza, tuttavia, risulta patologico: nella globalizzazione la perdita dei confini, che una volta conferivano maggiore forza alle differenze culturali, genera un senso di smarrimento e instabilità. Inoltre, la simbolizzazione occidentale rivela la sua fragilità proprio nell’assenza di “mancanza” o di negativo, una carenza che ne limita la capacità di rappresentare la realtà e di confrontarsi con l’alterità non-me. Identità è un concetto che De Micco esplora a fondo, soprattutto nei primi capitoli del suo viaggio. Essa non esiste mai in forma assoluta, indipendentemente dall’altro, ma è, da sempre, co-determinata. Nell’ambiente culturale, fatto di tanti altri, noi viviamo esperienze sensuali che ci trasformano e ci determinano così come noi determiniamo e trasformiamo gli altri. L’ambiente, anche naturale, entra, così, nella nostra identità: là abiterà, per sempre, continuamente rinnovato dall’apertura che sapremo offrirgli. A ciò si aggiunge il conflitto fondamentale che attraversa l’umano, quello tra desiderio e bisogno. In questa tensione simbolica, edipica, lo straniero rappresenta il padre. Spiega Thanopulos: il desiderio della madre per il padre costituisce il fondamento di una civiltà esogamica, aperta all’altro, in cui c’è spazio per lo straniero e per la differenza. Al contrario, la civiltà incestuosa è chiusa, indifferenziata (antedipica, direbbe Racamier) e nega il riconoscimento sia del padre-straniero sia della funzione simbolica della madre, che si dissolve lasciando spazio a configurazioni totalitarie. In queste società chiuse, l’arrivo degli altri —migranti, stranieri — li obbliga ad adattarsi a un sistema patologico che non li riconosce. Se adattarsi a un contesto che rifiuta la differenza delle loro identità produce disagio, anche la nostra società sviluppa patologie, seppur di tipo opposto: non manifestamente visibili, asintomatiche, come una “psicosi bianca”, espressione di un vuoto simbolico e relazionale sempre più profondo. Capire l’Altro e comunicare implica l’immergersi in una esperienza incarnata, dove il corpo e le emozioni plasmano il modo in cui diamo senso al mondo e agli altri: il pensiero affettivo nasce da lì e dà forma al linguaggio; perciò, è fondamentale che il migrante mantenga viva la propria lingua, per dare voce anche a quelle “Tracce traumatiche mute” che De Micco rileva, ad esempio, nel lavoro con il femminile migrante.
Identità, Corpo, Confine sono i tre luoghi che Luca Di Sciullo individua nel testo della De Micco. Tutto ha inizio dalla relazione intersoggettiva tra madre e bambino, linguisticamente mediata, che costituisce l’atto originante dell’identità umana. La madre parla al bambino con una visione affettiva che l’infante capta e di cui sembra avere un vitale bisogno (emblematico è l’esperimento condotto da Federico II di Svevia nel tentativo di scoprire la lingua “spontanea” degli esseri umani: affidati alcuni neonati a balie “mute”, se ne provocò la tragica morte per inedia). L’Identità, come De Micco evidenzia nel capitolo su “Le identità nomadi”, costituirebbe anche il precipitato di uno scambio fondato sul contratto narcisistico tra madre e bambino. Alle fondamenta vi sono l’essere amati dalla madre, l’essere destinatari del suo munus, del dono della relazione, ma anche la relazione col padre, portatore del dono della cultura, il patri-monio. Lo stesso Freud, in uno scritto del 1926, parlava di una “interiore identità”, di una propria “irresistibile attrazione per l’ebraismo e per gli ebrei”, della quale era assolutamente consapevole. Qualcosa che aveva a che fare, al tempo stesso, con l’essere e con l’appartenenza culturale. Cosa accade invece a quelle identità nomadi, che anziché avere radici esclusivamente verticali, ancorate nella propria tradizione culturale, hanno radici mobili, orizzontali, fluide, come dice Deleuze? Il dibattito con la sala si soffermerà a lungo su queste questioni identitarie, lasciate insature.
Il Corpo, sede delle pulsioni e dei bisogni, si configura come il luogo della fragilità e della necessità di cura. È attraverso il corpo che si manifesta la dipendenza radicale dell’essere umano, specialmente nei primi momenti della vita, quando il bisogno dell’altro è totale e ineludibile. L’esperienza migratoria, in questo senso, può assumere una valenza regressiva: riattiva e amplifica proprio quei bisogni di protezione, accudimento e riconoscimento che il corpo custodisce nella sua memoria profonda. De Micco lo sostiene fortemente, nel capitolo “Il corpo che migra: memorie, traumi, appartenenze”. Il corpo della persona migrante invece viene spesso negato, annullato.
Il Confine e il limite, conclude Di Sciullo, rappresentano quella frontiera che al tempo stesso contiene l’identità e rende possibile la relazione. La pelle è una soglia ambigua: è muro o passaggio? Frattura o connessione? È un sexus, che separa e unisce al tempo stesso. A chi appartiene il limite? A me o all’altro? Il limite, oggi sacralizzato come confine geografico da difendere, è diventato un non-luogo, una linea senza estensione, dove i migranti sono sospesi, fermi o come dice De Micco tragicamente immersi, ridotti ad una mano-cosa aggrappata ad una fune. Di Sciullo, con De Micco, sottolinea che il processo di soggettivazione si fonda soprattutto sulla parola, che si fa ponte tra le soggettività: i neonati dell’esperimento di Federico II morirono perché privati della comunicazione, perché noi viviamo delle parole degli altri. Nella migrazione, invece, l’atto parlante spesso manca: non si parla ai migranti, né con loro. Così come la madre immagina un bambino parlante, analogandolo a sé stessa, allo stesso modo si dovrebbe pensare/analogare lo straniero, affinché diventi parlante. Ecco che il metodo psicoanalitico, fondato sulla parola e sull’ascolto, assume ancora centralità.
Rapporti di forza, rapporti di senso. Valerio Petrarca, chiamato a concludere la prima parte dei lavori, offre una cornice interpretativa, un doppio asse, per dare senso ai fenomeni migratori. Cosa accade nei rapporti di forza che regolano le migrazioni? Cosa accade nei rapporti di senso, cioè nel modo in cui queste esperienze vengono vissute? Petrarca indica nella modernità e nelle scoperte geografiche di Mercanti, Militari e Missionari (le “tre M”), i primi motori delle moderne migrazioni. Figure occidentali con funzioni civilizzatrici e “unificanti dell’umano” sotto il segno della propria cultura, che hanno relegato la natura ad un piano inferiore. Eppure, accanto all’ideale umanista in cui noi occidentali ci riconosciamo — fondato su diritti, uguaglianza, dignità — esiste un altro volto, più cupo: uno spirito concentrazionario, che classifica, separa e marchia in base al colore della pelle, che produce esclusione mentre predica inclusione, che disumanizza mentre proclama valori universali. La promessa di eguaglianza, che venne esportata come rapporto di forza dalla civiltà occidentale, implicava una spartizione dei privilegi che è stata, di fatto, negata. I migranti che arrivano, vengono a completamento di quel viaggio civilizzatore intrapreso dai nostri antenati e cercano la realizzazione concreta di quei diritti che furono loro promessi: il diritto a muoversi, a migliorare la propria vita, a scegliere liberamente. È questo il rapporto di senso: la migrazione come risposta simbolica e concreta a un patto non rispettato.
Il dibattito è stato il valido indicatore della ricchezza di stimoli offerta dai relatori: non solo riflessioni teoriche, ma anche tante esperienze di suggestiva concretezza hanno punteggiato la lunga serie di interventi raccolti. Non era difficile riconoscere, nella molteplicità e diversità di voci, quella stessa polifonia di cui erano stati capaci i quattro relatori invitati e coordinati da De Micco. Ci si è così ritrovati, tutti, immersi in una relazione con l’Altro che non poteva non rimandare al tema in oggetto, alla relazione con il migrante così come con l’ospitante, al tema delle fratture, così ben sottolineato da più parti, e a quello dei legami, altrettanto ben evidenziati. Se Winnicott definì come “uso di un oggetto” la capacità di riconoscere l’Altro come “non me” e non come un fascio di proiezioni narcisistiche, allora, in quanto psicoanalisti, è importante riconoscere e dare pensabilità anche a tutti quei sentimenti ostili che, inizialmente, si esprimono nella distruttività di ciò che è altro e straniero, ma che rappresentano anche una premessa fondamentale per “usare” l’oggetto reale e per poterlo, infine, amare. Se, come suggerisce Ogden, “l’oggetto ha valore per me, perché è sopravvissuto al mio tentativo di distruggerlo”, allora non rimane che amare “lo straniero che è in noi, e con noi”.
*Anna Padula, Psicoanalista Associato SPI-IPA, Socia del CNP
Riferimenti Bibliografici
Freud, S. (1926), Discorso ai membri dell’associazione B’nai B’irth, OSF,vol X, Bollati Boringhieri
Ogden,T. H. (2022), “La distruzione riconcepita”, in Prendere vita nella stanza d’analisi, Cortina
Racamier, P.C. (1995), Incesto e Incestuale, tr.it. Franco Angeli
Winnicott, D. W. (1968), “L’uso di un oggetto e l’entrare in rapporto attraverso le identificazioni”,
in Esplorazioni psicoanalitiche, Cortina